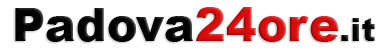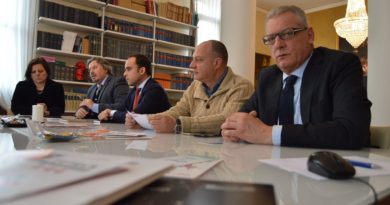L’intervista a Gino Gerosa, uscita qualche giorno fa sul Corriere della Sera mi ha emozionato e fatto arrabbiare, dato speranza e riempito di sgomento. Mi sono emozionato, perchè mi emoziona pensare di poter raccontare alle mie figlie di aver conosciuto un gigante di una semplicità disarmante. Andrebbe scritto un libro su questa persona mite, che incontri da solo mentre è andato a prendersi la bottiglietta d’acqua e si ferma con i familiari della persona che ha appena operato, a rassicurarli, sempre con tanta prudenza, e più che con le parole, con quegli occhi azzurri da montanaro ti dice “io ho fatto quello che potevo”. E quel che può fare Gino Gerosa con la sua equipe è tantissimo: scrive Stefano Lorenzetto nella bella intervista qui sotto ” Proseguendo sulla strada dell’innovazione, adesso il chirurgo e la sua équipe, che detiene il record dei trapianti cardiaci nel nostro Paese (39 nel 2016, 40 nel 2017) ed è la seconda in Europa per importanza, hanno creato il primo cuore bionico interamente «made in Italy».”.
L’intervista a Gino Gerosa, uscita qualche giorno fa sul Corriere della Sera mi ha emozionato e fatto arrabbiare, dato speranza e riempito di sgomento. Mi sono emozionato, perchè mi emoziona pensare di poter raccontare alle mie figlie di aver conosciuto un gigante di una semplicità disarmante. Andrebbe scritto un libro su questa persona mite, che incontri da solo mentre è andato a prendersi la bottiglietta d’acqua e si ferma con i familiari della persona che ha appena operato, a rassicurarli, sempre con tanta prudenza, e più che con le parole, con quegli occhi azzurri da montanaro ti dice “io ho fatto quello che potevo”. E quel che può fare Gino Gerosa con la sua equipe è tantissimo: scrive Stefano Lorenzetto nella bella intervista qui sotto ” Proseguendo sulla strada dell’innovazione, adesso il chirurgo e la sua équipe, che detiene il record dei trapianti cardiaci nel nostro Paese (39 nel 2016, 40 nel 2017) ed è la seconda in Europa per importanza, hanno creato il primo cuore bionico interamente «made in Italy».”.
Ecco quei numeri sono la vetta di una montagna di speranza che viene alimentata ogni giorno nel reparto di cardiochirurgia che ho avuto l’avventura di frequentare giusto un anno fa, non da paziente, ma da familiare di un mio carissimo zio. Lì dentro ogni settimana una persona riceve il cuore da un altro uomo che non c’è più. E già questo è un miracolo. Ma poi centinaia rinascono dopo essere stati a un passo dalla morte. E Gino Gerosa quelle persone le va a trovare tutte, prima e dopo l’intervento. E guarda negli occhi i suoi pazienti, spiega loro ciò che avverrà e il più delle volte, con quelle mani che sono ispirate dalla scienza e forse anche da Dio.
Da una quindicina d’anni Gino Gerosa e un gruppo di innovatori visionari si sono messi in testa di far funzionare un nuovo cuore nel petto dei pazienti che non hanno alternative. Un progetto che chissà quante notti ha tolto a quel professore che insegna, salva vite e nel tempo che gli avanza è papà di una splendida famiglia. Un progetto che con coraggio la Fondazione Cassa di Risparmio ha finanziato per un milione di euro. Che sembrano pochi, ma che sono una bazzecola per una ricerca di livello mondiale come quella che Gerosa e i suoi hanno in animo di portare in fondo, dopo aver fatto funzionare il prototipo.
Non ho visto comparire questa priorità, trattenere a Padova una delle poche eccellenze di livello europeo che rimangono, nei discorsi recenti di sindaco, Rettore e Presidente della Camera di commercio. Ecco, io credo che sarebbe bellissimo se nei prossimi giorni queste tre autorità convocassero il professore Gerosa e gli dicessero: “Siamo a disposizione, dicci come possiamo aiutarti” magari accompagnati anche dal presidente della Confindustria e da quelli delle principali fondazioni bancarie. Successe già anni fa: i veneti si costruirono da soli, senza fondi statali le autostrade, la zona industriale; con un importante finanziamento europeo realizzarono uno dei più importanti mercati agro alimentari d’Europa. Ora è possibile fare altrettanto: non costruire una infrastruttura fatta di cemento e metri cubi, ma una realtà fatta di ricerca e sapere, ed anche umanità. Sii felice, Padova, che costudisci un tesoro, scolpirono i padovani secoli or sono a lettere cubitali dorate sulla volta dell’Arca del Santo. Ecco, fatte le debite proporzioni e senza scomodare Sant’Antonio, credo che questo tesoro chiamato medicina e nuova salute, sia importante custodirlo. Altrimenti quando e se mai avremo costruito la cassaforte grandissima dell’ospedale a Padova est, rischieremo magari di scoprire che nel frattempo ci siamo fatti rubare tutti i gioielli più preziosi.
Alberto Gottardo
Questa l’intervista a Gino Gerosa apparsa sul Corriere della Sera di venerdì 5 ottobre
Il cardiochirurgo Gerosa: «Ho creato il cuore bionico, non vorrei produrlo in Cina»
Lo specialista, allievo di Ross, il «rivale» di Barnard:«Rivoluziona i trapianti perché non servono più i farmaci antirigetto»

Due erano i capisaldi del cardiochirurgo morto quattro anni fa nella capitale britannica: coraggio e innovazione. Il suo erede veneto li ha trasformati in standard. Nel 2007 fu il primo in Italia a eseguire l’impianto di un cuore artificiale su un paziente di 54 anni, tuttora vivo, che poi nel 2011 ricevette l’organo da un donatore. E poche settimane fa Gerosa è stato il primo al mondo a rimuovere una massa dalla parte sinistra del cuore di una paziente settantenne, senza fermare il muscolo contrattile e senza l’ausilio della circolazione extracorporea, con una tecnica microinvasiva che esclude l’uso del bisturi, analoga a quella utilizzata per la plastica della valvola mitralica. Ben 200 dei 900 interventi eseguiti finora a livello planetario con questa metodica sono avvenuti nell’unità operativa padovana intitolata al professor Vincenzo Gallucci, il predecessore di Gerosa.
Proseguendo sulla strada dell’innovazione, adesso il chirurgo e la sua équipe, che detiene il record dei trapianti cardiaci nel nostro Paese (39 nel 2016, 40 nel 2017) ed è la seconda in Europa per importanza, hanno creato il primo cuore bionico interamente «made in Italy».
Ce n’era davvero bisogno?
«Sì, perché l’unico cuore non umano disponibile, il Cardiowest, concepito dopo la seconda guerra mondiale negli Stati Uniti dallo stesso inventore olandese che ideò il rene artificiale, condanna a una pessima qualità di vita».
Come mai?
«Non batte: soffia. Quindi ha bisogno di un compressore esterno molto rumoroso, del peso di 7 chili, che produce l’aria necessaria a movimentare la membrana racchiusa fra due gusci di poliuretano. Per di più le quattro valvole meccaniche richiedono una terapia farmacologica a vita».
Da quanto lavora al cuore bionico?
«Dal 1988, quando facevo training da Ross a Londra. La svolta giunse nel 2007 da due veneti, esperti in impianti hi-fi. Avevano progettato un orologio da polso che misurava pressione, indice glicemico, colesterolo e cercavano un consulente medico. Finimmo a parlare del cuore bionico. Di lì a qualche mese tornarono da me con il disegno di un tubo. Obiettai: ma vi pare che possa impiantare questo aggeggio nel torace di un uomo?».
E loro?
«Modificarono lo schizzo. A quel punto mi emozionai, perché anche nell’embrione il cuore comincia a forma di tubo e, dopo varie flessioni e rotazioni, assume le quattro camere cardiache e i vasi aortopolmonari. In pratica era l’anticipazione dell’attuatore, il meccanismo fondamentale del cuore bionico».
Per quale motivo lo ha chiamato così?
«Alla parte elettronica unisce quella biologica, costituita da un rivestimento di pericardio bovino decellularizzato».
Servono terapie dopo il trapianto?
«Gli antiaggreganti. Invece con il Cardiowest anche gli anticoagulanti».
E nei trapianti tradizionali?
«Il cuore del donatore è un organo estraneo, quindi vanno somministrati per sempre farmaci antirigetto. Nei primi dieci anni dall’intervento la qualità di vita è ottima, tant’è che il trapiantato torna al lavoro. Ma poi possono instaurarsi gli effetti collaterali della terapia immunosoppressiva: insufficienza renale, infezioni, linfomi, tumori cutanei».
Dimensioni del cuore bionico?
«Appena 8,5 centimetri, contro i quasi 15 di cui abbisogna il Carmat messo a punto in Francia».
Dura per sempre?
«E il cuore umano dura per sempre?».
Già, niente è per sempre nel corpo.
«Appunto. Un’auto messa su un circuito alla velocità costante di 100 chilometri orari dopo sei mesi avrebbe percorso 432.000 chilometri e sarebbe da buttar via. Il cuore pulsa 70 volte al minuto, circa 100.000 al giorno, 3 miliardi di battiti nella vita media. Ecco perché una durata superiore ai cinque anni per quello bionico è già un successo, tenuto conto che poi si può sempre impiantarne un altro».
L’avete testato?
«Sì, abbiamo fatto una prova di banco per mimare le condizioni fisiologiche, pompando 10 litri di acqua contro una pressione di 120 millimetri di mercurio. Perfettamente riuscita. Ora stiamo lavorando al motore lineare elettrico, che avrà il vantaggio di essere silente».
Alimentato in che modo?
«Con una batteria esterna. Ma stiamo sviluppando un sistema di trasmissione transdermica dell’energia, per cui la ricarica avverrà con le radiofrequenze all’interno delle stanze».
Il cuore bionico è stato brevettato?
«Certo, già da due anni, in tutta la Ue».
Da chi?
«Da noi. Ci siamo autotassati».
Non posso crederci.
«Abbiamo sborsato di tasca nostra 20.000 euro. Ma per estendere il brevetto agli Stati Uniti ne servono altri 40.000».
Chi sono questi «noi»?
«Il laboratorio di medicina rigenerativa diretto dalla biologa Laura Iop, due ingegneri, i due inventori e il qui presente».
Che cosa manca perché il cuore bionico venga prodotto in serie?
«Un gruppo che finanzi lo sviluppo definitivo del prototipo e del motore miniaturizzato elettrico nonché la sperimentazione animale e umana. Finora abbiamo avuto 1 milione di euro dalla Fondazione Cariparo. Ne servono altri 50».
Dove pensa di trovarli?
«Ho fatto il giro di fondazioni bancarie, industrie farmaceutiche, imprenditori, raccogliendo tante pacche sulle spalle».
Ha cercato tra i fondi d’investimento?
«Ho bussato anche alla loro porta. La prima domanda è stata: “Recuperiamo nei primi cinque anni il doppio di quanto investiamo?”. Qualcuno mi ha chiesto persino se poteva guadagnarci cinque o dieci volte tanto. Ora, benché il cuore bionico venga a costare 80-100.000 euro, contro i 60.000 del Cardiowest, io faccio il cardiochirurgo, mica il finanziere. Come posso garantire gli abnormi profitti che questi signori si aspettano?».
Da ministero della Salute, Università di Padova e Regione Veneto niente?
«Il governatore Luca Zaia ha già erogato 3,5 milioni per il laboratorio di medicina rigenerativa. Non posso obbligarlo anche a fabbricare il cuore bionico».
Se non troverà i fondi, che farà?
«Arrivato a questo punto, non lascio di sicuro il lavoro a metà».
Allora mi sa che dovrà emigrare.
«Prego il buon Dio di non trovarmi nelle condizioni di lasciare il Paese che amo per andare a realizzare il cuore bionico in Cina, negli Stati Uniti o in Russia».
I cinesi potrebbero essere interessati?
«Secondo lei perché Giovanni Tria, il ministro dell’Economia, è volato a Pechino? Ma io mi ostino a pensare di trovare ascolto in Italia. Lancio un appello: anziché richiamare i cervelli dall’estero, fate lavorare noi romantici che siamo rimasti qui».
Quanto costa un trapianto di cuore da donatore in morte cerebrale?
«Più di 80.000 euro».
E lei non teme che l’organo bionico metta a repentaglio una ricca filiera?
«No, perché i due tipi d’intervento sono sinergici. Se un paziente non sopporta la terapia antiaggregante, tocca per forza ricorrere al cuore umano».
A 50 anni dal Rapporto di Harvard che introdusse il criterio di morte cerebrale, rendendo possibili gli espianti, non crede che occorra una riflessione?
«È importante una riflessione sul fatto che oggi l’espianto avviene anche nei casi di morte cardiaca, la quale in Italia per legge viene decretata dopo almeno 20 minuti continui di elettrocardiogramma piatto, in altri Paesi dopo soli 10 o 5».
Lei è donatore di organi?
«Sì. E anche i miei tre figli».
Che cosa prova quando ha fra le mani un cuore battente?
«Un’enorme responsabilità, perché so di poter causare la morte del paziente».
Su quanti cuori ha operato?
(Conta mentalmente). «Circa 7.000».
Il paziente più piccolo?
«Un neonato del Napoletano affetto da neoplasia ventricolare sinistra. Gli abbiamo trapiantato l’organo di un bimbo, 12 mesi di vita, morto per trauma cerebrale in un tamponamento fra auto».
Ha capito perché il cuore è ritenuto la sede dei sentimenti e del coraggio?
«Le risponderò con le parole che mi disse il padre di Francesco Busnello, il ragazzo di Treviso, morto cadendo dal motorino, che consentì di salvare Ilario Lazzari, primo italiano a ricevere un cuore nuovo in questo ospedale nel 1985: “Sa, professore, incontrando il trapiantato, ero sicuro di cogliere qualcosa di mio figlio. Invece in lui non c’era nulla che mi ricordasse Francesco”. Lì ho avuto la certezza che l’individualità di una persona risiede nel cervello, non nel cuore».
Stefano Lorenzetto